Libri 1/Italiani brava gente – Davide Conti, L’occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della “brava gente” (1940-1943), Odradek 2008, p. 275, euro 18
L’occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della “brava gente” (1940-1943), Intervista a Davide Conti
di Paolo Persichetti
Liberazione 5 settembre 2008

Nel Sergente della neve Mario Rigoni Stern descrive la disastrosa ritirata dell’Armir dell’inverno 1942-43 come una tragica epopea umana dove non c’è odio ma rispetto per i nemici, dove i soldati italiani fraternizzano con i contadini delle pianure del Don. Nel racconto traspare la consapevolezza per la condizione comune vissuta dagli uomini contro che bivaccavano nelle trincee scavate sulle linee opposte del fronte. Pubblicato nel 1953, il racconto di Rigoni Stern è divenuto una sorta di libro di testo per generazioni di scolari, una pedagogia pacificata piuttosto che pacifista della nostra memoria. Le avventure coloniali e le guerre d’aggressione del regio esercito e delle milizie fasciste scolorano fino a cancellarisi in una narrazione addolcita, nostalgica, senza rivalse e rancori ma anche senza gli orrori della guerra di conquista, gli eccidi, gli sterminii dei civili, la pulizia etnica, le politiche di snazionalizzazione delle popolazioni autoctone condotte da Mussolini in Africa, nei Balcani e in Russia. Il conflitto bellico sembra seguire le regole non scritte d’un galateo cavalleresco d’altri tempi. Il «generale inverno», la fame, i topi e le «cordate di pidocchi» che risalgono il collo dei nostri alpini appaiono i soli veri nemici da combattere. Questo libro ci ha aiutato a odiare la guerra sui banchi di scuola, a capirne tutta la sua insensatezza, ma ha anche riassunto e divulgato il mito del “bravo italiano”, del nostro «colonialismo straccione» e quindi dal volto umano, privo di ferocia, esente da crimini bestiali. Un’epica degli ultimi che troviamo anche in Italiani brava gente, film di Giuseppe De Santis uscito nel 1964. L’internazionalismo, la divisione per classi e non per nazionalità, l’antieroismo, la solidarietà tra russi e italiani poveri, la critica feroce degli stati maggiori fino a rappresentare i soldati italiani come vittime inconsapevoli delle loro gerarchie, nutrono un racconto didascalico che nel tentativo di educare al rifiuto della guerra, all’antimilitarismo e ai valori della fratellanza tra i popoli, getta un velo ideologico sulla condotta reale delle nostre truppe. È singolare che la cultura di sinistra, sia pur giustificata da intenti lodevoli, abbia contribuito con la sua narrazione nazionalpopolare alla rimozione delle responsabilità italiane nella seconda guerra mondiale, facilitando quel rovesciamento di paradigma storiografico che l’attuale egemonia culturale della destra erede del fascismo sta portando a termine con successo. Affrontiamo la questione con Davide Conti, giovane storico ricercatore della Fondazione Basso, che ha recentemente pubblicato per le edizioni Odradek (prima edizione già esaurita), L’occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della “brava gente” (1940-1943), 2008, p. 275, euro 18.

Nei Balcani le truppe italiane hanno lasciato alle loro spalle una scia orribile di massacri. «Qui si ammazza troppo poco», disse una volta il generale Mario Robotti. Com’è possibile che i palikuca, i «bruciatetti», così le popolazioni civili chiamavano gli italiani, siano diventati nel dopoguerra «brava gente»?
In realtà l’immagine autoassolutoria del “bravo italiano” è rimasta una rappresentazione nazionale ben poco condivisa all’estero. Al termine del secondo conflitto mondiale tutti i paesi occupati dal regime fascista, Jugoslavia, Grecia, Albania, Urss, Francia ed Etiopia, chiesero alla commissione internazionale per i crimini di guerra l’estradizione dei militari italiani accusati di violenze. Gli Usa e l’Inghilterra condannarono a morte alcuni militari del regio esercito responsabili di crimini contro i prigionieri alleati. La legenda degli italiani “brava gente” emerse solo in un secondo tempo, nel quadro dei nuovi equilibri provocati dalla Guerra Fredda. Quest’immagine, sostenuta poi dagli stessi Alleati, fu utilizzata per legittimare il rapido riarmo dell’Italia e la sua integrazione nell’Alleanza Atlantica.
Non credi che insieme ad una rimozione dei crimini dei militari ascrivibile alla cultura della destra, vi sia stata anche una involontaria omissione da parte della sinistra?
Tra il 1944 ed il 1945 tutti i partiti della sinistra sostennero la necessità di estradare i responsabili italiani delle violenze nei paesi occupati. Successivamente il coinvolgimento nei governi di unità nazionale e la presenza di socialisti e comunisti all’interno della Commissione d’inchiesta sui crimini di guerra rese problematico mantenere una linea intransigente. Il biennio 46-47 fu un momento decisivo. La sconfitta delle posizioni più avanzate in termini di rinnovamento dello Stato e l’arresto delle epurazioni ebbe ripercussioni anche sull’apertura dei processi per crimini di guerra. Dopo l’esclusione dal governo e la sconfitta elettorale del 1948, la questione assunse un peso prevalentemente polemico-propagandistico fino a dissolversi nella “normalizzazione” post-bellica.
Il fatto che il nostro paese abbia subito una dura occupazione militare e una feroce guerra civile non ha forse contribuito alla rimozione delle spedizioni coloniali e dei loro crimini. Il dolore di casa nostra non ha forse oscurato quello altrui?
Di fronte alla commissione che venne istituita dal ministero della Guerra, un alto esponente del regio esercito utilizzò a sua discolpa proprio quest’argomento per attenuare le responsabilità italiane nei bombardamenti dei villaggi jugoslavi. Disse che le distruzioni di abitati civili non erano diverse dai bombardamenti subiti dalle città italiane. In sostanza sosteneva che in guerra i crimini contro le popolazioni civili trovavano un senso e una giustificazione nell’eccezionalità della situazione storica.

Quale è l’odierno utilizzo del mito del bravo italiano?
Fatte salve le ovvie differenze con le forze armate attuali, credo che il perdurare del mito risieda nell’assoluta attualità e funzionalità che la rappresentazione dell’italiano brava gente assume oggi nelle cosiddette “missioni di pace” dei nostri militari. Domandiamoci quanto abbia inciso nel consenso dell’opinione pubblica, soprattutto quella di sinistra più sensibile ai temi della pace, la retorica del “bravo italiano”, della “Missione Arcobaleno” durante la guerra in Kosovo, dell’intervento “umanitario e di ricostruzione” in Afghanistan, per poi finire con l’Iraq? In queste operazioni militari tutti i governi hanno utilizzato a piene mani l’immagine del soldato italiano elemento di “pace” e “normalizzazione” delle aree di crisi internazionale, marginalizzando il ruolo militare e di combattimento delle nostre truppe anche in contesti di aperta violazione del diritto internazionale.
Non ritieni che il discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica Napolitano nel febbraio 2007, in occasione della “Giorno del ricordo”, appartenga a quel modello di narrazione storica costruita attorno al paradigma del vittimismo memoriale?
Il discorso di Napolitano si colloca all’interno di un vero e proprio “corto circuito della memoria”. Ne parlo nell’ultimo capitolo del libro. Sulle foibe Napolitano parlò di “pulizia etnica” contro gli italiani. Gli rispose il presidente croato Mesic ricordando la ferocia e gli eccidi dell’occupante fascista. Replicò infine D’Alema sostenendo che anche partigiani italiani avevano combattuto valorosamente insieme alle brigate jugoslave contro i fascisti, riscattando in questo modo l’Italia. Ora delle due l’una: o gli italiani che affiancavano gli jugoslavi erano interni al progetto di pulizia etnica anti-italiana……oppure la pulizia etnica non c’entra nulla e le ragioni storiche che spiegano la complessa e drammatica vicenda delle foibe sono da rintracciarsi in altri elementi. Quando lo storico Raul Pupo intervenne sulla rivista dell’Anpi di Roma, Persona e Società, del giugno 2006, spiegò che i fattori alla base delle uccisioni del 1943 e poi del 1945 dovevano essere ricercati non tanto nella relazione causa-effetto, innescata dall’occupazione italiana e successiva reazione jugoslava, quanto nelle particolari dinamiche della storia della Jugoslavia del tempo. Questo cambio di prospettiva analitica, che pone al centro la storia jugoslava e non la sola lettura italiana, potrebbe consentire una comprensione reale degli eventi.

Quali sono le novità documentali presenti nel tuo libro rispetto alle ricerche precedenti?
I documenti sono in larga parte inediti e certificano, attraverso resoconti dettagliati delle operazioni militari, che le truppe del regio esercito commisero stragi, rappresaglie, internamenti, deportazioni e distruzioni in danno di civili, partigiani e militari di altri paesi. Inoltre si palesa l’intento programmatico del governo fascista e delle alte gerarchie militari di realizzare politiche di “snazionalizzazione” dei territori occupati e di terrore programmato per il controllo dell’ordine pubblico. Si riportano lunghi elenchi di presunti criminali di guerra italiani di cui i paesi occupati chiedono l’estradizione (circa 1200). Si menzionano luoghi, tempi e modalità in cui vennero svolte operazioni militari contro le popolazioni locali e si individua la catena di comando. Il fatto che tali documentazioni provengano da fonti militari e ministeriali e da relazioni dirette di soldati italiani e non siano solo accuse di provenienza jugoslava rafforza l’elemento di verità storica e a mio avviso lo pone come fattore non marginale di impegno pubblico rispetto ai conti con la nostra storia nazionale.
Perché il ministero della Difesa rende ancora inaccessibili quei documenti che possono fare luce sui comportamenti delle forze armate nelle imprese coloniali italiane?
L’allargamento del dibattito e una maggiore sollecitazione dell’opinione pubblica potrebbe rappresentare un grimaldello efficace per ottenere finalmente l’accesso alle fonti militari. Nel febbraio 1996, al termine di una lunga disputa tra Angelo Del Boca e Indro Montanelli sull’uso dei gas in Africa, il ministro della Difesa dell’allora governo Dini, il generale Domenico Corcione, intervenne in Parlamento per confermare ciò che sosteneva Del Boca, sancendo una verità storica fino ad allora negata.
Nelle polemiche rivolte alla vicenda delle foibe o del “triangolo rosso” emiliano non vi è il tentativo di confondere quella che è stata la «guerra civile» con la «guerra sistematica ai civili» condotta dai nazifascisti dentro e fuori il territorio italiano?
Confondere la guerra civile con la “guerra ai civili” significa dare adito alle forme peggiori di revisionismo. Uniformando sotto il criterio di una indefinita “violenza” elementi completamente diversi per natura, origine e sviluppo, porta alla conclusione che da una parte e dall’altra vi fu lo stesso grado di crudeltà e che in sostanza le due parti contendenti abbiano una uguale moralità e dignità storica. Le diversità tra nazifascisti e antifascisti vengono in questo modo cancellate favorendo la costruzione di quel “senso comune” che ha permesso in questi ultimi anni un vero e proprio processo mediatico alla Resistenza, ridefinendo in termini di egemonia nella società il primato di una cultura di destra anche nell’ambito della lettura della storia nazionale. La “guerra ai civili” fu una strategia militare adottata dalle truppe nazifasciste nei territori occupati dell’Europa per mantenere il controllo dei paesi invasi dalle truppe dell’Asse ed in Italia le stragi tedesche ne rappresentano la più triste conferma.
Sui crimini di guerra commessi dal nostro esercito nei Balcani è tornata ad indagare anche la magistratura militare dopo che, nel 2002, è venuta meno la clausola della reciprocità sancita dall’art. 165 cp. Ma gli eventuali processi non avranno comunque un esito penale effettivo poiché i responsabili sono scomparsi. Non c’è il rischio di delegare all’ambito giudiziario la ricerca storica?
Quella clausola venne utilizzata per negare le estradizioni dei nostri militari, mettendo sullo stesso piano aggressori e aggrediti. La “scoperta” dei fascicoli riguardanti le stragi tedesche e le responsabilità dei collaborazionisti salotini rappresenta un elemento di grande importanza dal punto di vista storico e civile. Ritengo molto importante che il procuratore militare Intelisano abbia riaperto il caso dei crimini di guerra italiani all’estero. Credo che forme di sanzione giuridica siano in questo caso specifico assolutamente importanti. Sarebbe mai stato possibile costruire il mito del “bravo italiano” se si fossero celebrati i procedimenti giudiziari contro i nostri criminali di guerra? Ciò non avrebbe favorito un ricambio quantomeno dei vertici militari e dell’alta burocrazia rendendo percorribile e più incisiva la strada dell’epurazione e del rinnovamento delle istituzioni? In sostanza quella tara storica della “continuità dello Stato” patita nel dopoguerra dalla stessa Repubblica democratica e antifascista avrebbe trovato terreno meno fertile per radicarsi nel tessuto nazionale. L’immagine evocativa, utilizzata da Filippo Focardi, della mancata “Norimberga italiana” rappresenta in questo senso un elemento centrale della storia dell’Italia post-fascista.
Ma il processo di Norimberga non ha affatto denazificato la Germania. Non è una tragica illusione credere che i processi nei tribunali possano compensare ciò che non è riuscito ai processi storici? Così non si rischia di scadere dal tribunale della storia alla storia dei tribunali?
Naturalmente il lavoro giudiziario è diverso da quello storico cui competono altre funzioni rispetto alla ricerca sul piano penale e di responsabilità individuali che sono proprie dell’ambito giuridico. Sta alla ricerca storica non subordinare esclusivamente il proprio lavoro alla dimensione giudiziaria. Il problema risiede poi nella capacità di sedimentare nella coscienza dell’opinione pubblica ciò che emerge dalle carte e dai documenti. È poi ovvio che un processo di generale rinnovamento sociale, politico e culturale di un paese non possa essere delegato in toto ad un ambito giuridico o soltanto storico. Sono processi che per riuscire nel loro compito necessitano della attiva ed ansiosa spinta di rinnovamento delle società.

I crimini del colonialismo italiano dall’Africa alla Jugoslavia
«La favola del bono italiano deve cessare […] per ogni camerata caduto paghino con la vita 10 ribelli. Non fidatevi di chi vi circonda. Ricordatevi che il nemico è ovunque; il passante che vi saluta, la donna che avvicinate, l’oste che vi vende il bicchiere di vino […] ricordatevi che è meglio essere temuti che disprezzati»
Generale Alessandro Pirzio Biroli
«È necessario eliminare tutti i maestri elementari, tutti gli impiegati comunali e pubblici in genere (A.C., Questura, Tribunale, Finanza, ecc.), tutti i medici, i farmacisti, gli avvocati, i giornalisti…, i parroci…, gli operai…, gli ex militari»
Generale Orlando
«Logico ed opportuno che campo di concentramento non significhi campo d’ingrassamento»
Generale Gambara, 17 dicembre 1942
1934 Tripolitania e Cirenaica vengono riunite per formare la colonia di Libia. Alla Libia viene attribuito l’appellativo di quarta sponda. Per gran parte degli anni 20 le autorità italiane sono impegnate in una sanguinosa pacificazione durante la quale si fece ricorso ai gas asfissianti e alla deportazione di 100 mila persone che provocò la morte a 15 mila di queste.
Ottobre 1935 100 mila soldati italiani occupano l’Abissinia (attuale Etiopia), estendendo il dominio coloniale già presente in Eritrea dalla fine dal 1879 e in Somalia dal 1889. Anche qui vi fu l’impiego sistematico di bombe all’Iprite (solfuro di etile biclorurato), di bombardamenti a tappeto dell’aviazione sui civili e di esecuzioni in massa dei prigionieri. Massimi responsabili i generali Del Bono e Graziani.
Aprile 1939 Alla vigilia della seconda guerra mondiale, una settimana dopo la conclusione della guerra di Spagna del 1936-39, viene annessa l’Albania.
Ottobre 1940 Aggressione della Grecia.
 Aprile 1941 L’invasione congiunta del regno di Jugoslavia da parte della Germania nazista, della Bulgaria, dell’Ungheria e dell’esercito dell’Italia fascista, porta alla spartizione della Slovenia, con annessione all’Italia della provincia di Lubiana; occupazione del Montenegro con inclusione della Bosnia, entrambi trasformati in protettorato italiano; creazione di uno Stato fantoccio croato (appoggiato dal Vaticano), alla cui testa viene messo Ante Pavelic, nominato poglavnik (duce), capo del movimento d’estrema destra Ustascia, clone nazi-fascista. Varo immediato di leggi razziali, massacri di civili, deportazioni, conversioni religiose forzate al cattolicesimo, apertura di otto campi di concentramento contro Serbi, Ebrei e Zingari. 400 mila morti nel campo di concentramento di Jasenovac (il terzo per grandezza in Europa). Regio esercito emilizie fasciste si rendono responsabili di distruzioni, incendi di centri abitati e fucilazioni di massa di civili e prigionieri. 26 mila montenegrini vengonointernati.
Aprile 1941 L’invasione congiunta del regno di Jugoslavia da parte della Germania nazista, della Bulgaria, dell’Ungheria e dell’esercito dell’Italia fascista, porta alla spartizione della Slovenia, con annessione all’Italia della provincia di Lubiana; occupazione del Montenegro con inclusione della Bosnia, entrambi trasformati in protettorato italiano; creazione di uno Stato fantoccio croato (appoggiato dal Vaticano), alla cui testa viene messo Ante Pavelic, nominato poglavnik (duce), capo del movimento d’estrema destra Ustascia, clone nazi-fascista. Varo immediato di leggi razziali, massacri di civili, deportazioni, conversioni religiose forzate al cattolicesimo, apertura di otto campi di concentramento contro Serbi, Ebrei e Zingari. 400 mila morti nel campo di concentramento di Jasenovac (il terzo per grandezza in Europa). Regio esercito emilizie fasciste si rendono responsabili di distruzioni, incendi di centri abitati e fucilazioni di massa di civili e prigionieri. 26 mila montenegrini vengonointernati.
Luglio 1941 Invio di un corpo di spedizione italiano in Russia-Armir di circa 220 mila uomini.

Pulizia etnica. Il Mladic italiano
ll generale Mario Roatta fu uno dei più feroci esponenti della politica militarista di Mussolini
Paolo Persichetti
Liberazione 18 settembre 2008
 Paolo Persichetti
ll generale Mario Roatta fu uno dei più feroci esponenti della politica militarista di Mussolini. Nato a Modena nel 1887, divenne capo del Sim (servizio segreto militare) dal gennaio 1934 al settembre 1936, quando prese il comando del corpo di spedizione italiano in Spagna. Dal 1941 al 1942 è capo di stato maggiore. Comanda la seconda armata in Slovenia e Croazia, dove ordina l’eliminazione dei civili sospetti di ribellione, attua la pulizia etnica e organizza il sistema dei lager per i civili slavi. Torna ad essere capo di stato maggiore fino al novembre 1943. Viene contattato dall’Oss, il servizio segreto progenitore della Cia, perché organizzi una pre-Gladio. Il 16 novembre 1944 viene arrestato per la mancata difesa di Roma. Il 4 marzo del 1945 evade dall’ospedale militare con la complicità dei dei carabinieri e del Sim appena ricostituito. Una settimana dopo la fuga arriva la condanna all’ergastolo perché ritenuto uno dei mandanti dell’assassinio dei fratelli Rosselli. Ripara nella Spagna di Franco. Rientra in Italia nel 1966 grazie ad alcune amnistie. Muore a Roma nel 1968. Una sua foto è tuttora appesa alle pareti dell’Archivio storico dello Stato maggiore dell’esercito.
Paolo Persichetti
ll generale Mario Roatta fu uno dei più feroci esponenti della politica militarista di Mussolini. Nato a Modena nel 1887, divenne capo del Sim (servizio segreto militare) dal gennaio 1934 al settembre 1936, quando prese il comando del corpo di spedizione italiano in Spagna. Dal 1941 al 1942 è capo di stato maggiore. Comanda la seconda armata in Slovenia e Croazia, dove ordina l’eliminazione dei civili sospetti di ribellione, attua la pulizia etnica e organizza il sistema dei lager per i civili slavi. Torna ad essere capo di stato maggiore fino al novembre 1943. Viene contattato dall’Oss, il servizio segreto progenitore della Cia, perché organizzi una pre-Gladio. Il 16 novembre 1944 viene arrestato per la mancata difesa di Roma. Il 4 marzo del 1945 evade dall’ospedale militare con la complicità dei dei carabinieri e del Sim appena ricostituito. Una settimana dopo la fuga arriva la condanna all’ergastolo perché ritenuto uno dei mandanti dell’assassinio dei fratelli Rosselli. Ripara nella Spagna di Franco. Rientra in Italia nel 1966 grazie ad alcune amnistie. Muore a Roma nel 1968. Una sua foto è tuttora appesa alle pareti dell’Archivio storico dello Stato maggiore dell’esercito.
Link
Nuovi documenti e prove sui lager fascisti
I redenti
Politici e amnistia, tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’unità d’Italia ad oggi
L’amnistia Togliatti
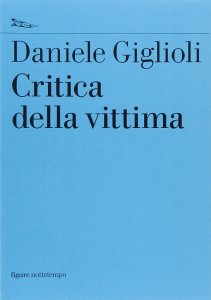 «In primo luogo la memoria, l’ossesione della memoria. Il dovere, addirittura, della memoria, un termine che nel nostro spirito pubblico aspira a spodestare, come ha notato Enzo Traverso, il suo gemello/antagonista storia. Rispetto alla storia, la memoria è soggettiva, intima, vissuta, non negoziabile, autentica se non vera a prescindere: assoluta proprio perché relativa. Configura un rapporto col passato di tipo inevitabilmente proprietario: il mio, il nostro passato.
«In primo luogo la memoria, l’ossesione della memoria. Il dovere, addirittura, della memoria, un termine che nel nostro spirito pubblico aspira a spodestare, come ha notato Enzo Traverso, il suo gemello/antagonista storia. Rispetto alla storia, la memoria è soggettiva, intima, vissuta, non negoziabile, autentica se non vera a prescindere: assoluta proprio perché relativa. Configura un rapporto col passato di tipo inevitabilmente proprietario: il mio, il nostro passato.








